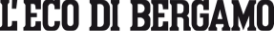Il piacere di leggere / Bergamo Città
Lunedì 23 Agosto 2021
La casa: muta promessa di «felicità condivisa»
Emanuele Coccia, docente di filosofia presso l’École des hautes études en sciences sociales di Parigi, propone una «Filosofia della casa», ossia un’analisi filosofica dei significati legati all’idea del nostro habitat principale/privilegiato.
Antropocene. Negli anni in cui il peso degli oggetti artificiali, dei manufatti, ha superato quello di tutti gli esseri viventi sul pianeta (biomassa), la riflessione sul nostro rapporto con loro ha occupato un ruolo di primo piano, dalle filosofie del «Solo bagaglio a mano», del non farsi imprigionare dai legami con il materiale, al tema delle «Cose da salvare», della selezione, magari drammatica, fra irrinunciabile e rinunciabile. In questo quadro amplissimo, che ha visto contributi di pensiero dagli Usa al Giappone, Emanuele Coccia, docente di filosofia presso l’École des hautes études en sciences sociales di Parigi, propone una «Filosofia della casa», ossia un’analisi filosofica dei significati legati all’idea del nostro habitat principale/privilegiato, in cui l’Io si appropria e insieme si adatta a un pezzettino di mondo.
Di case Coccia, che ha lavorato a New York, Parigi, Tokyo, Friburgo, Düsseldorf, Baires, ne ha vissute parecchie: «Cambio casa in media una volta all’anno», magari da una parte all’altra dell’oceano, da Montreuil alla Grande Mela . «Porta dopo porta ho aperto e chiuso negli anni più di trenta case», trenta «collezioni di pareti», mobili, ricordi, ma soprattutto amori, presenze, vite altrui: un piccolo quartiere, popolato da abitanti che, tra loro, nemmeno si conoscerebbero. Il suo approccio è lontano da quello, per esempio, di un Gabriele Romagnoli (massima libertà da vincoli, «senza nulla sei venuto e senza nulla te ne andrai»), pur se, in entrambi, il trasloco è uno snodo rivelatore. Per il giornalista «un trauma liberatorio», che ci rivela la superfluità di gran parte delle cose che ingombrano i nostri spazi domestici e esistenziali. Per Coccia «l’equivalente profano e quotidiano di quello che nei miti è il giudizio universale: si separano i dannati dagli eletti, si traccia una frontiera che si vorrebbe nettissima tra il passato e il presente, e si fa di tutto perché coincida con quella tra il dolore e la felicità». La casa è, infatti, per lui, non, come da consolidato stereotipo, la tana, il rifugio, lo spazio inviolabile dell’individualità, ma una muta promessa di «felicità condivisa». Una «forma spaziale per vivere l’amore, in tutte le sue manifestazioni».
Proprio il suo «dongiovannismo domestico» lo ha indotto a stilare, in questo libro, un ragionato elenco di ciò che fa di un luogo una casa, il simbolo, per eccellenza, del ritorno: pregando che ne valga la pena.
© RIPRODUZIONE RISERVATA