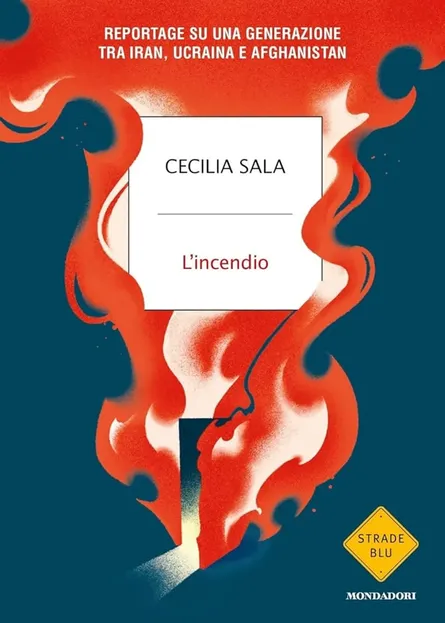Cecilia Sala è stata liberata dal carcere di Evin a Teheran, dove era detenuta dal 19 dicembre 2024 con l’accusa di «aver violato le leggi della Repubblica islamica dell’Iran». L’annuncio è di pochi minuti fa. La giovane giornalista italiana, già protagonista di numerose esperienze come reporter in zone di guerra, si trovava in isolamento totale, con condizioni di detenzione durissime. Il suo arresto – Cecilia era partita da Roma il 12 dicembre per l’Iran con in mano un regolare visto giornalistico – ha scosso non solo l’Italia, ma l’intero scenario geopolitico internazionale. Solo pochi mesi fa, a luglio esattamente, la reporter è stata ospite a Nembro della rassegna culturale «Migliori di Così». Per l’occasione Eppen l’aveva intervistata, soffermandosi in modo particolare sulla situazione in Afghanistan, in Sudan e a Gaza, oltre al conflitto tra Russia e Ucraina. Felici della notizia della sua liberazione e con l’augurio di abbracciare presto Cecilia a Bergamo, riproponiamo l’articolo a lei dedicato.
Cecilia Sala. Classe 1995, giornalista de Il Foglio e scrittrice, Cecilia Sala è autrice di numerosi reportage (soprattutto dall’America Latina e dal Medio oriente), nonché di « Stories », podcast di Chora Media che, quotidianamente, racconta in modo semplice e pulito fatti e avvenimenti di interesse internazionale. L’abbiamo intervistata per Eppen.
FR: Cecilia Sala, lei è diventata celebre nel 2021, grazie al rigore professionale e al coraggio dimostrati nel seguire la caduta dell’Afghanistan nelle mani dei talebani. Oggi di Afghanistan non si parla quasi più. Qual è la situazione in cui versa questa nazione? Quale quella delle sue donne?
CS: In Afghanistan, da quando i talebani hanno preso il potere, c’è una crisi umanitaria spaventosa (oltre a esserci, naturalmente, una crisi dei diritti civili). Questo perché un gruppo di persone che era abituato soltanto a combattere si è ritrovato ad amministrare una nazione senza saperlo fare. Un conto è tenere in braccio un fucile; un conto, invece, è garantire la sicurezza di un aeroporto o gestire il sistema sanitario nazionale e la banca centrale o fare manutenzione antisismica delle miniere, in un Paese dove, all’anno, muoiono circa mille persone a causa dei terremoti. L’Afghanistan aveva bisogno di aiuti economici internazionali già prima dell’arrivo dei talebani al governo; adesso ne avrebbe bisogno ancora di più. Ovviamente, però, gli aiuti non arrivano: i talebani sono sulla «black list» di moltissimi stati occidentali. È bene ricordare, inoltre, come ancora oggi in Afghanistan le scuole siano chiuse: è l’unico Paese al mondo dove le donne (di qualsiasi età) non possono studiare.
FR: Anche del Sudan si parla poco. Che idea si è fatta della guerra civile in corso?
CS: Il Sudan ha sempre dato pochi visti giornalistici: è soprattutto questo il motivo per cui se ne parla poco. A livello mediatico, è poco coperto. Basti pensare che, per tutta la prima fase della guerra (iniziata il 15 aprile del 2023), i visti sono stati zero. Adesso, pian piano, si stanno aprendo le porte ai giornalisti internazionali ma, per quasi un anno dall’inizio del conflitto, è stato praticamente impossibile varcare i confini di questa nazione. In questo momento, c’è una città assediata: Al Fashir (un milione e ottocento persone, un tempo, prima del colonialismo, la capitale del Darfur indipendente). Le Nazioni Unite hanno chiesto il cessate il fuoco e la fine dell’assedio, ma queste richieste non sono state ascoltate dalle RSF (Rapid Support Forces, ndr), ovvero da parte dei paramilitari. La guerra in Sudan, infatti, è una guerra fra l’esercito regolare e un’organizzazione militare composta principalmente dalle milizie «janjawid».
FR: Nell’episodio 568 del suo podcast, parlando dell’approvazione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del piano di “Cessate il fuoco” a Gaza, lei afferma che bisogna guardarsi dai sabotatori. Chi sono coloro che, secondo lei, non vogliono la pace in Terra Santa? Perché?
CS: Entrambi i leader degli schieramenti in campo non hanno molto da guadagnare nel mettere fine alla guerra. Con molta probabilità, la cessazione del conflitto segnerebbe la conclusione del mandato da primo ministro di Benjamin Netanyahu, che rischierebbe di comparire davanti a un tribunale in Israele e, forse, pure davanti alla Corte penale internazionale dell’Aia, per crimini di guerra. Difficile, invece, a mio avviso, che a Gaza un’eventuale fase di ricostruzione avrà come protagonista il leader di Hamas, Yahya Sinwar (abituato a essere il capo indiscusso della Striscia). È per questo che i negoziati continuano ad arrancare.
FR: Ha avuto senso, secondo lei, non convocare la Russia alla prima Conferenza di pace sull’Ucraina svoltasi qualche giorno fa a Lucerna?
CS: La conferenza di Lucerna non aveva l’ambizione di arrivare alla pace, bensì fissare qualche paletto, se così si può dire: il ritorno dei ventimila bambini ucraini rapiti (che sono ancora in Russia), per esempio, o la messa in sicurezza di tutte le installazioni nucleari, come Zaporižžja. Ad ogni modo, dialogare con Putin (accettando le sue richieste massimaliste e senza garanzie) è molto difficile: ne parlo nell’episodio 573 di «Stories».
FR: Ne «L’incendio. Reportage su una generazione tra Iran, Ucraina e Afghanistan» (Mondadori, 2023), lei racconta i desideri, le lotte ma anche le disillusioni dei giovani che vivono in nazioni dilaniate dalla guerra e dalla mancanza delle libertà fondamentali. Secondo lei, il destino di questa generazione di ventenni è ineluttabilmente segnato o esiste un’alternativa a un futuro di odio e di miseria?
CS: La situazione più tragica, dove è difficile trovare luce e speranza, è senza ombra di dubbio l’Afghanistan. Non direi esattamente lo stesso dell’Ucraina e dell’Iran. Rispetto a due anni fa, Kyiv è molto cambiata: ci sono cinema all’aperto, ci sono più concerti e festival che a Roma; è una capitale viva, piena di gente, con un maggior numero di abitanti rispetto a prima dell’inizio dell’invasione russa. Non è detto che le cose vadano sempre peggio: ci sono percorsi a volte impossibili, spesso faticosi o dolorosi, però ci sono movimenti che, a lungo andare, portano a dei cambiamenti significativi. Persino nell’Afganistan che, fra i luoghi che racconto, come detto, è il più disperato, ci sono storie di resistenza: penso, per esempio, agli adolescenti di sesso maschile che stanno più attenti in classe perché, una volta tornati a casa, devono fare lezione alle loro sorelle; ma anche ai conduttori, uomini, che protestano in solidarietà alle loro colleghe (costrette a coprirsi corpo e viso col burqa) o i medici che rifiutano di laurearsi in medicina se non possono laurearsi anche quelle donne che hanno dato tutti gli esami. Il titolo del mio libro non ha un’accezione soltanto negativa: non evoca soltanto la distruzione, ma anche il fuoco della ribellione (e del desiderio di libertà) che divampa.
FR: Lei, spesso in territori di guerra, è costantemente a contatto con il pericolo. Qual è il suo rapporto con la paura e con la morte? A tal proposito, c’è per caso un episodio che vorrebbe narrare?
CS: A marzo 2022, mi trovavo a Kyiv: nessuno aveva ancora la certezza che la capitale si sarebbe salvata, che i russi non sarebbero stati in grado di prenderla. L’atmosfera era surreale, sicuramente spaventosa, le sirene per i bombardamenti suonavano in continuazione, le strade erano deserte. Ero arrivata alla stazione durante il coprifuoco, ero uscita dal sottopasso con le mani alzate: una impugnava una bandiera bianca, fatta con l’asciugamano da bidet rubato a questo scopo in un hotel della città di Chmel’nyc’kyj. Kyiv era chiusa e le autorità dicevano che chiunque fosse stato trovato in giro sarebbe stato sospettato di essere un sabotatore russo. All’improvviso, vengo fermata da un miliziano: mi domanda chi sono, mi punta il fucile addosso, intimandomi di aprire la mia borsa. Il controllo, però, dura fino a quando non sentiamo il rumore di due esplosioni vicine. Ci guardiamo in silenzio, come a dire che, a quel punto, abbiamo entrambi qualcosa di più urgente da fare; nel mio caso, trovare riparo. Ecco, io credo che il pericolo sia sempre dietro l’angolo; che di fronte a esso le reazioni di ognuno di noi, per quanto diverse, siano in un certo senso molto simili e che, se fai il mestiere che faccio io, con la paura e con la morte alla fine impari a conviverci.