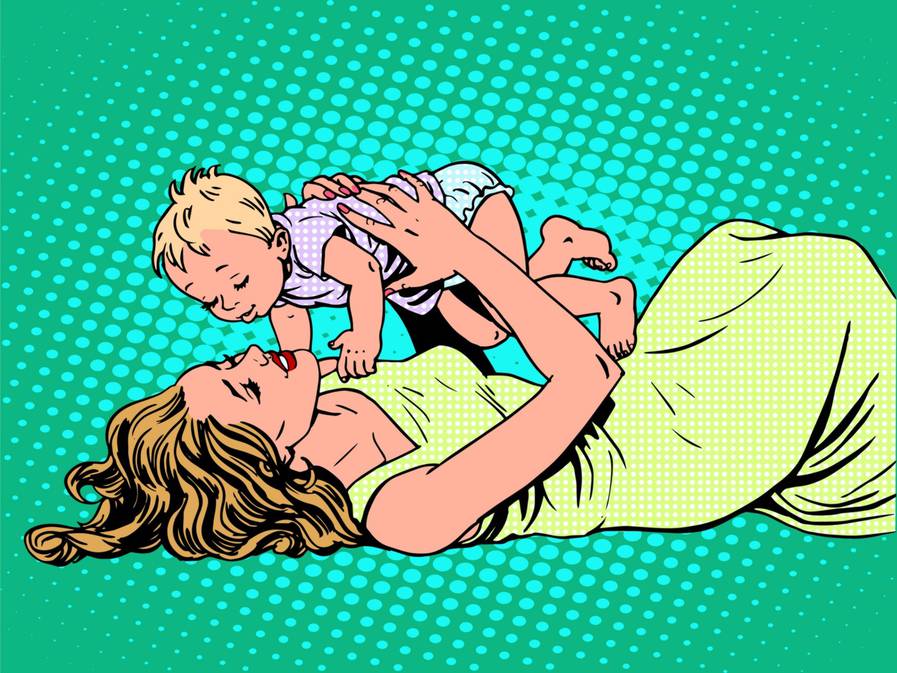Quando la mia amica Elisabetta ha cominciato il corso preparto, l’ostetrica l’ha messa con un gruppo di altre mamme davanti a un cartellone, con dei pennarelli in mano. L’indicazione era di disegnare le loro paure e aspettative, associando un aggettivo ad ogni lettera della parola “parto”. Nessuna ha mai avuto cuore di rivelare all’ostetrica che la loro paura maggiore si stava già concretizzando: quella di regredire dallo stato di adulte – con un lavoro, ambizioni, passioni, persone interessanti da frequentare, esami da dare (la mia amica stava prendendo il dottorato in Fisica), libri da leggere, cose da fare – a un gruppo di bambine dell’asilo armate di pennarelli Carioca a punta grossa.
L’infantilizzazione della donna incinta: quello strano fenomeno per il quale si suppone che un’impeccabile professionista si trasformi all’improvviso in una creatura irrazionale dominata dagli ormoni. È solo una delle tante ragioni per cui fare figli non è un’opzione molto appetibile, quantomeno per una donna di oggi. Nata dagli anni ’70 in poi, con un lavoro fuori casa, un titolo di studio oltre la terza media e un rapporto paritario con il compagno (sto ovviamente semplificando).
Quando leggo che i figli per donna in Italia sono 1,35 non mi stupisco siano pochi, mi stupisco che non siano ancora meno. E non mi riferisco a tutte quelle ragioni concrete che rendono difficile conciliare l’essere una donna moderna, nell’accezione più ampia possibile, con l’essere madre. Non parlerò di asili nido, parità di accesso al mondo del lavoro, potere salariale, flessibilità. Tutte cose che contano moltissimo. Ma ce n’è un’altra, meno misurabile, ma in cui siamo costantemente immersi: il nostro immaginario collettivo.
La donna perfetta
Non esiste oggi una narrazione realmente positiva dell’essere madre. Il modello di “madre” è fermo al secolo scorso o a due secoli fa: accogliente, amorevole, accudente, votata al sacrificio, felice e appagata nel suo ruolo. A questo stereotipo si sovrappone quello della donna moderna, senza che sia stata operata una sintesi fra i due modelli. Per cui da una giovane donna ci si aspetta che abbia figli, ma solo dopo avere studiato – attenzione però a non metterci troppo oppure l’orologio biologico comincerà a ticchettare. Si pretende che abbia un lavoro e possibilmente un buon lavoro (altrimenti è una mantenuta), riuscendo al contempo a prendersi cura in prima persona dei bambini, altrimenti “Cosa li hai fatti a fare?”. Però in ufficio nessuno dovrebbe nemmeno accorgersi che ha dei figli, altrimenti significa che approfitta della sua condizione per fare di meno, e si meriterebbe di essere licenziata. Poi è necessario che sia materna, ma curata: “Non vorrai lasciarti andare?”, e deve fare tutto questo per istinto e senza sforzo. Insomma, non è una situazione molto diversa da quella descritta da Angela Finocchiaroin un celebre sketch di fine anni ’80. Solo che ora, comprensibilmente, le giovani donne si chiedono: ma chi me lo fa fare?
Il ludibrio delle pancine
Soprattutto, una madre non deve essere una “pancina”. Questo neologismo ha preso piede velocissimamente prima sul web e poi nel comune parlare, dando voce al fastidio condiviso per tutti gli aspetti considerati più retrivi della maternità, quando non per la maternità stessa. Una pancina è una madre ignorante e ottusa, che giudica negativamente le donne senza figli e si dedica a pratiche arcaiche, tipo riconoscere il sesso del nascituro dalla forma della pancia o allattare fino alla maggiore età (dei figli, non la sua).
Metà degli sforzi miei e delle mie amiche con figli sono volti a fugare ogni dubbio di essere una pancina. Non mostriamo mai pubblico compiacimento per avere avuto un bebè. Ci sentiamo in colpa se bidoniamo un aperitivo o una cena, se non lavoriamo fino alle otto di sera, se i nostri figli fanno i capricci in pubblico. E non prendiamo nemmeno in considerazione l’ipotesi di farne più di uno o due (c’è un pregiudizio sociale fortissimo verso chi ha tre figli o più, un’opzione considerata praticabile solo dagli ultra ricchi o dagli ultra poveri e ignoranti).
In una parola: ci scusiamo e ci giustifichiamo per essere madri. Se la maternità, un tempo, conferiva status, ora lo toglie. A meno di non avere tutte le risorse – economiche, sociali, familiari – per continuare a essere perfette in tutto, o almeno per fare finta di, come nello sketch dalla Finocchiaro.
Il modello ironico
A fare da contraltare al modello della “donna perfetta”, sta prendendo piede un altro tipo di narrazione: quella ironica della madre imperfetta. Il web è pieno di video buffi di mamme che raccontano i lati “nascosti” della maternità: quelle che confessano di nutrire i figli con merendine confezionate invece che con farro biologico, che ironizzano sulla difficoltà di trovare il tempo per farsi una doccia o telefonare a un’amica, che vorrebbero solo a mollare i bambini per andare a bersi un mojito. Oppure che non dormono una notte di fila da anni e non riescono nemmeno a sedersi sulla tazza del wc. Alcuni sono meglio di altri, come quelli della Pozzolis Family che hanno almeno il merito di mostrare come la genitorialità possa essere condivisa e carica di creatività. Sono contenuti per certi versi molto liberatori, ma non rispondono alla fatidica domanda: ma chi te lo fa fare?
Mission Impossible
Uno dei pericoli di questa narrazione “al negativo” della maternità è quella di farne una missione impossibile e una vocazione specialissima. Uno status symbol o un atto di eroismo. Un percorso a ostacoli cui solo le più preparate, capaci e motivate possono partecipare.
C’è chi, fin da bambina, ha sempre saputo di volere diventare madre. Chi lo ha sempre escluso. Ma anche chi non sa, è possibilista, non è convinta.
La riflessione più frequente, fra le mie amiche trentenni, è: “Ma io non so se voglio veramente un figlio”. E intendiamoci: interrogarsi è fondamentale, altrimenti saremmo conigli che si riproducono per solo istinto e non persone raziocinanti. Ma non essere sicure è normale, e non farà di noi delle cattive madri nel caso decidessimo di “buttarci”.
Chi non ha figli capisce benissimo
Al “Ma chi te lo fa fare?” corrisponde una risposta data per scontata un po’ da tutti, tanto che non c’è quasi bisogno di esplicitarla: l’amore di un figlio vale tutto e ripaga di tutto. E solo dopo averlo provato si può capire. È un tipo di narrazione banale, che somiglia molto all’ultima riga delle favole: “E vissero tutti felici e contenti”.
Lasciatemi essere sincera fino in fondo: non è vero.
Non c’è nessuna rivelazione mistica che si accompagna al parto. O, se esiste, io non l’ho provata. Non fraintendetemi: sono contenta di avere avuto mio figlio, lo trovo un bambino molto simpatico e mi ha di sicuro aiutato a essere una persona migliore. Ma non vivo in uno stato di perenne beatitudine per il solo fatto che lui esista e – scoop – la mia vita andava bene (e male) anche prima. Non ero incompleta, non ero infelice.
Dov’è la gioia?
Mi ha molto colpito un passo dell’enciclica “Amoris Laetitia” di Papa Francesco:
“Ad ogni donna in gravidanza desidero chiedere con affetto: abbi cura della tua gioia, che nulla ti tolga la gioia interiore della maternità. Quel bambino merita la tua gioia. Non permettere che le paure, le preoccupazioni, i commenti altrui o i problemi spengano la felicità di essere strumento di Dio per portare al mondo una nuova vita”.
Mi sento capita dal Papa meglio che da tante altre madri, meglio che da tante amiche, meglio che da una narrazione della maternità che è piatta, banale, incolore. Nero su bianco il Papa scrive che la gioia, nella maternità, non è scontata. Che esistono paure, preoccupazioni, commenti altrui (tacete!) e problemi che possono spegnerla. Allo stesso tempo ci ricorda una cosa semplice, tanto semplice che la perdiamo di vista: un bambino merita la nostra gioia.
Ma quindi, perché?
Quando ero incinta, affranta per la mia mancanza di senso materno (non riuscivo ad avere cura della mia gioia interiore, parafrasando l’“Amoris Laetitia”), la frase migliore me l’ha detta la mia amica Antonella, biologa e nullipara: “Guarda che il senso materno non è avere gli occhi a cuoricino, è fare in modo che tuo figlio sopravviva. Secondo me ce la puoi fare”. Oltre a farmi molto ridere, ho capito subito che aveva ragione.
Credevo che, quando avessi avuto un bebè, avrei maturato idee più chiare sui pro e i contro. Non è così, semplicemente perché non è una scelta che si possa mettere a bilancio, come quella di cambiare lavoro o comprare una casa più grande. Non mi permetterei mai di consigliare – nemmeno all’amica più cara, figuriamoci a una sconosciuta – se fare o non fare un figlio. Posso solo darvi alcune delle mie ragioni, in ordine sparso, e mai da nessuna parte ci troverete l’amore. Perché quello ve lo avranno già raccontato e quando si mette nero su bianco diventa una menzogna.
Mettersi alla prova #1. Fare un figlio è una prova fisica e morale, come prepararsi a una scalata in montagna. E – come accade in montagna – non si guadagna niente, non c’è un premio o un traguardo finale. Come rispose non so quale alpinista famoso, alla domanda sul perché avesse scalato non so quale vetta (non sono un asso nelle citazioni): “Perché è lì”. È una sfida con i propri limiti, una scoperta di sé stessi prima ancora che di altro.
Mettersi alla prova #2. È il momento di confutare tutte le teorie pedagogiche, dimostrare che gli altri non ci hanno capito niente e che noi riusciremo ad avere un bambino educato ma non represso, felice ma non chiassoso, altruista ma capace di farsi rispettare, intelligente ma non sapientino. Un piccolo che dormirà la notte, mangerà sano, non sarà intrattenuto dagli schermi. E intanto noi non ci abbruttiremo. Disclaimer: la riuscita di questo secondo punto non è garantita.
Diventare migliori. Niente come un figlio ti obbliga a fare alcune cose, anche se non ne hai voglia. A mangiare le verdure a ogni pasto e non mettere troppo sale, a svegliarti presto la mattina anche se hai fatto tardi, a non dire le parolacce, a non essere maligna, a sorridere anche quando non ne hai voglia, a organizzarti, a fare dieci cose contemporaneamente (a volte anche bene) quando prima ne facevi tre e già era difficile. Un bebè è più inflessibile di un personal trainer, più motivante di un capo severo.
Per curiosità. Voglio vedere come sarà questo figlio, come diventerà, a chi somiglierà. Ripercorrere le tappe della sua evoluzione e, grazie a lui, rimanere in contatto (senza, per carità, farne parte) con le generazioni più giovani: sapere cosa pensano, come vivono, che sogni hanno, se possono aiutarmi a scaricare nuovi programmi sul computer.
Perché le persone muoiono. Questa è una dura verità, che stranamente non vedo mai citata quando si parla di nascite. Io ho la fortuna di avere una famiglia allargata con la quale mi trovo molto bene: zii interessanti, cugine simpatiche, nonni meravigliosi. Non volevo che a Natale fossimo sempre e solo noi, ogni anno più vecchi, ogni anno di meno. Sentivo l’esigenza di mettere in scena qualche nuovo personaggio, per rinverdire la compagnia.
Perché voglio diventare nonna. Sul diventare madre avevo dei dubbi, ma sull’essere nonna no, soprattutto dopo avere visto l’effetto del bambino su mia madre e mia suocera. So che per realizzare questo sogno dovrò avere la collaborazione di mio figlio, ma potrò ben rompergli le scatole chiedendo di farmi un nipotino. Una frase trita, che non vedo l’ora di fare mia.
Non ci ho messo l’amore, come vedete, ma non ho inserito in elenco nemmeno calcoli egoistici tipo “Mi pagherà la badante”. Anche perché per quello basterebbe investire la spesa di un figlio in un fondo pensione e, probabilmente, il rendimento economico sarebbe migliore. Procreare o meno non è una scelta che si possa fare con una bilancia in mano.
Per andare di qualche punto percentuale sopra la media di 1,35 figli per donna servirebbero tante misure concrete. Tra le cose immateriali che mancano: una narrazione della maternità come di un evento normale. Non una scelta obbligata, per carità, ma serenamente possibile per una varietà di donne, le più diverse. Anche quelle che non amano in particolare modo i bambini (io non mi sono mai sentita Maria Montessori, ma volevo un figlio lo stesso), che non hanno pazienza, che hanno altri obiettivi nella vita, che non vogliono rinunciare a ciò che sono, che non si sentono conformi. Perché siamo tutte diverse, e non basta il braccialetto del reparto maternità per trasformarci in uno stereotipo vivente.