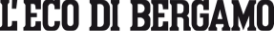Universo Bergamo / Bergamo Città
Sabato 18 Gennaio 2025
Il giro del mondo nella ricerca dell’Università di Bergamo
Studi in laboratorio, analisi sul campo, esperimenti e passione fanno parte del lavoro quotidiano di oltre 900 studiosi che nell’Ateneo orobico lavorano ai progetti di ricerca e portano il mondo a Bergamo. Quello che presentiamo qui è un viaggio nella ricerca che UniBg porta avanti, e che prende avvio nell’ambito della sostenibilità.
Ci sono tanti motivi per scegliere Bergamo, e uno di questi è quello di studiare nella sua Università. Fondata nel 1968 l’UniBg si è trasformata nel corso dei decenni in un campus diffuso che abbraccia la città e la sua provincia. Oggi conta 8 Dipartimenti, in cui si svolge anche una ricca e diversificata attività di ricerca e si progettano ed erogano programmi formativi innovativi, al passo con i cambiamenti del mercato del lavoro.
In questo viaggio a puntate nel mondo accademico ci focalizzeremo sulla ricerca all’interno dei vari Dipartimenti di UniBg, approfondendo volta per volta un ambito diverso. E la prima puntata è dedicata alla sostenibilità.
Come definire l’Ateneo bergamasco? «Un’Università che guarda al futuro», un «motore di sviluppo» in grado di far dialogare il mondo della cultura, dell’innovazione e della sostenibilità. Così si è presentato in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico 2024/25. Passe-partout in questo senso è la ricerca che consente di mantenere uno sguardo attento e curioso verso i temi che costituiranno il futuro della società. Gli studenti di oggi potranno diventare i ricercatori del domani ed è quindi fondamentale l’investimento nella ricerca.
La ricerca accende il dialogo tra le discipline
Ad emergere sono alcuni aspetti chiave: l’internazionalizzazione come valore aggiunto in molti dei progetti di ricerca che nasce attraverso la collaborazione con docenti, ricercatori e dottorandi provenienti da tutto il mondo. La qualità dei Centri di ricerca che promuovono un approccio interdisciplinare. Infine uno sguardo ai numeri della ricerca nel polo bergamasco: dal personale (con attenzione al tema del genere) ai progetti finanziati grazie a bandi competitivi nazionali e internazionali.
Un dato positivo emerge dal numero di iscritti ai corsi di dottorato di UniBg che sono aumentati: da 160 nel 2021 si è passati ai 220 del 2024. Come ha ricordato il rettore Sergio Cavalieri, si sono fatti numerosi passi avanti durante i primi tre anni di mandato: l’istituzione del Centre for healthy longevity , due nuovi corsi di dottorato, il Landscape Studies for global and local challenges e Health and longevity e il tavolo interdisciplinare sull’Intelligenza Artificiale.

Il 2025 sarà anche l’anno in cui l’ateneo bergamasco redigerà il 1° bilancio di sostenibilità. Un altro progetto promosso dalla cattedra Unesco, presieduta da Alberto Brugnoli, è la creazione della «Piattaforma multi-attoriale» per «capitalizzare la transizione verde derivante dal Green Deal e dal Piano industriale verde dell’Ue, quale strumento per la trasformazione strutturale del territorio».
In Europa e nel mondo
Non a caso la parola chiave è universo, perché le connessioni che partono da UniBg raggiungono metaforicamente tutto il globo e, dal mondo, tornano “verso” Bergamo. La reciprocità e lo scambio che queste connessioni creano dimostrano l’apertura all’innovazione e lo sguardo al futuro per migliorare l’attività di ricerca e arricchirla di contaminazioni. Sono circa 100 i paesi di afferenza dei ricercatori con cui la ricerca made in Bergamo si confronta e dialoga. Analizzando le pubblicazioni co-autorate da docenti e ricercatori di UniBg con ricercatori di Università estere, si osserva che la rete di collaborazioni scientifiche va ben oltre i confini europei, estendendosi a tutti i continenti.
La proiezione internazionale è incoraggiata anche da una serie di misure: il programma che finanzia annualmente la mobilità in entrata di professori e ricercatori provenienti da atenei, organismi di ricerca, istituzioni estere, e la mobilità in uscita dei ricercatori bergamaschi. Per il 2025 l’Ateneo sosterrà la mobilità in ingresso e in uscita di oltre cento ricercatori.
Il bilanciamento di genere
Le attività di ricerca, che si svolgono negli otto dipartimenti dell’Ateneo e nei Centri di ricerca, contano oltre 900 persone tra docenti, ricercatori, assegnisti di ricerca e dottorandi. Una lettura in prospettiva di genere fa emergere un quadro bilanciato, con un numero di donne impiegate nella ricerca di poco inferiore rispetto a quello degli uomini: sul totale degli studiosi in UniBg il 55% sono uomini e il restante 45% sono donne. Inoltre se il dato viene rapportato a quello nazionale (del rapporto Anvur 2023) emerge un quadro più roseo, per la categoria dei professori. Le professoresse donne ordinarie rappresentano quasi il 40% nel polo bergamasco mentre a livello nazionale la percentuale è del 27%. La percentuale di associate invece sale oltre il 45% a Bergamo e resta ferma al 42% in Italia.
Finanziamenti a una ricerca multiforme
L’Ateneo punta ad un approccio interdisciplinare e a coprire diverse aree di ricerca. Ne sono testimonianza i progetti finanziati con bandi competitivi nazionali e internazionali. È questo uno degli elementi chiave per poter attrarre risorse e nuovi talenti che scelgono Bergamo per fare della ricerca il proprio lavoro.
Entrando più nello specifico UniBg conta 138 progetti di ricerca finanziati con bandi nazionali e 20 con bandi internazionali, su tematiche che afferiscono a molteplici ambiti. Oltre trenta quelli su clima, energia e mobilità (34), poi c’è il settore della salute (31) e la sicurezza civile per la società (33). Spazio viene dedicato anche alla ricerca scientifica sui temi della cultura, creatività e società inclusiva (23), del digitale, industria e spazio (20) e prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente (14).
Incubatori di idee
Ulteriore punto di forza sono i Centri di ateneo di ricerca e terza missione con focus specifici. L’Healthy Longevity è il più recente, che integra ricerca di base e applicata per affrontare le sfide legate alla longevità nei contesti lavorativi e negli ambienti di vita.
Il centro per il trasporto e la mobilità sostenibile esplora temi legati al trasporto aereo, alla mobilità urbana ed extra-comunale e al turismo.
Di cambiamenti socio economici e giuridici a livello globale, europeo e locale si occupa il Centro sulle dinamiche economiche, sociali e della cooperazione, invece le attività di pianificazione urbanistica e territoriale, di fruizione del territorio (turismo sostenibile e studio dei paesaggi storici) sono gestite dal Centro studi sul territorio.
Il Center for Young and Family Enterprise è impegnato nella ricerca sull’imprenditorialità giovanile e familiare, mentre il CisAlpino Institute for Comparative Studies in Europe approfondisce le politiche pubbliche, con focus l’istruzione universitaria. A completare il quadro il Centro interuniversitario sull’innovazione e la gestione dei servizi nelle Imprese Industriali.
Tre facce della sostenibilità: sociale, ecologica e digitale
Il tema della sostenibilità è al centro del progetto di eccellenza del Dipartimento di Scienze Aziendali , riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca tra i 180 Dipartimenti di Eccellenza delle Università statali di tutto il territorio italiano.
Nell’ambito di questo programma i ricercatori e le ricercatrici del DIPSA stanno sviluppando progetti di ricerca che analizzano come le diverse tipologie di aziende (imprese profit e non profit, intermediari finanziari, istituzioni pubbliche ed enti del terzo settore) plasmano e sono plasmati dai processi di cambiamento di natura sociale, tecnologica ed ecologica in atto. Tra le tematiche oggetto di analisi ci sono: l’integrazione della responsabilità sociale e ambientale nella strategia aziendale e nei modelli di business, i modi con cui le aziende misurano e rendicontano gli impatti delle attività, le relazioni tra ESG e scelte di finanziamento e investimento, gli impatti delle dinamiche demografiche, delle emergenze sanitarie e dei fenomeni climatici estremi sui mercati e sulle decisioni e processi delle aziende, le dinamiche di genere e l’attenzione alle diversità in azienda.
Tre esempi di ricerca capaci di alimentare il dibattito scientifico a livello internazionale e al contempo offrire indicazioni pratiche per affrontare le sfide contemporanee, rafforzano il ruolo di UniBg nel panorama della conoscenza. «Perché alcune imprese rinunciano alla certificazione B Corp?» è la domanda a cui il cui gruppo di ricerca composto dalle professoresse Mariarosa Scarlata e Cristina Bettinelli, con lo studioso Federico Mangiò, sta provando a rispondere. Aiutare le aziende a rimuovere gli ostacoli che portano all’ottenimento di un riconoscimento che è garanzia per clienti e fornitori.
Il secondo ambito di ricerca verte su come creare valore sostenibile nel tempo, ma anche come distribuirlo tra i diversi attori politici ed economici. Il tema viene approfondito attraverso l’analisi delle correlazioni tra le aziende che hanno o non hanno il rating Esg. A condurre gli studi è un team eterogeneo guidato dai professori Silvana Signori e Gianfranco Rusconi, insieme ai colleghi stranieri, Leire San-Jose e Josè Luis Retolaza.
Di Equity Crowdfunding si occupa, invece, il professore di finanza imprenditoriale, Silvio Vismara che evidenzia come studi recenti indicano che un numero crescente di piattaforme di crowdfunding integrano i criteri di sostenibilità nella selezione delle imprese, migliorando così la loro capacità di attrarre investitori e la loro performance.
L’acqua tra rischi globali e sfide per la società
L’acqua è fondamentale per il benessere umano, gli ecosistemi e l’economia. La sua disponibilità e gestione influenzano salute pubblica, produzione agricola e industriale e stabilità ecologica e politica.
Un recente evento organizzato da UniBg dal titolo «Chiedilo all’acqua» ha reso noti i risultati della ricca attività di ricerca in corso, aprendosi al dialogo con il territorio. Tra questi gli studi sull’uso dell’acqua nella produzione industriale e le pratiche di economia circolare, tema che si intreccia con il rating ESG e alla disclosure aziendale.
Ma l’acqua in UniBg è analizzata anche nella sua valenza socio-culturale. La percezione che abbiamo di essa influenza profondamente il suo utilizzo e conservazione, mentre la sua presenza o assenza modella i territori e le società. Quando associata a eventi estremi come alluvioni, l’acqua da risorsa si trasforma in un fattore di rischio. Studi condotti in UniBg si concentrano sullo sviluppo di soluzioni finalizzate a prevenire i rischi dei cambiamenti climatici. Tra queste: infrastrutture resilienti, manutenzione dei sistemi di difesa del territorio, rimboschimento e gestione virtuosa di aree boschive, interventi di drenaggio urbano, de-impermeabilizzazione e rinaturalizzazione di aree antropizzate.
«JustWater» è il progetto che, in modo esemplificativo, rende testimonianza della qualità del lavoro di Unibg. A questo tema la ricercatrice Francesca Greco, esperta di politiche idriche e vincitrice della prestigiosa borsa di ricerca «Marie Curie», si sta dedicando da più di un anno presso il Dipartimento di Lingue Letterature e Culture Straniere.
Di cosa tratta? Del cibo che mangiamo che contiene acqua, cosiddetta virtuale, ossia invisibile: «perché è quella che è servita per produrlo – spiega Greco –, ma non tutta l’acqua virtuale è la stessa: alcune sono più vulnerabili, altre sottoposte a forte stress idrico e situazioni di siccità».
L’obiettivo della ricerca è comprendere, concentrandosi sul territorio della nostra Penisola, se e come vengono esportate le derrate alimentari da corpi idrici in cattivo stato. Un secondo aspetto della ricerca, nonché novità assoluta che permetterà di arricchire la letteratura sull’acqua virtuale, è anche l’analisi della dimensione del genere investigando il ruolo delle donne nelle politiche idriche italiane. Un terzo focus affrontato da Greco sono i distretti agricoli che esportano di più, con supporto di dati della Commissione Europea e di strumenti, come i software Gis «che permettono la mappatura e l’analisi di dati geolocalizzati». Ulteriore punto di forza della ricerca è quello di promuovere la “citizen’s scienze”, dove a farsi partecipi sono i cittadini stessi che potranno accedere e contribuire ai dataset e alle informazioni prodotte da Enti di ricerca e Università.
Un domani più sostenibile
La transizione ecologica non può prescindere da un’attenzione specifica al patrimonio edilizio e dall’adozione di nuove modalità di produzione e consumo dell’energia. Questi temi sono oggetto di numerosi studi in UniBg, in particolare nell’ambito del Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate. demolire ma ammodernare ed efficientare.
Il patrimonio edilizio è il tema chiave del progetto approfondito con l’aiuto della ricercatrice Chiara Passoni, che insieme al team di studiosi di cui è parte, si occupa di sviluppare soluzioni ingegneristiche per migliorare la sostenibilità e la sicurezza di quello che è oggi un patrimonio edilizio obsoleto e caratterizzato da diverse vulnerabilità.
La strada non è quella di demolire ma ammodernare ed efficientare. La visione che si applica nello studio delle soluzioni ingegneristiche ed edili è quella del Life Cycle Thinking individuando criteri progettuali ispirati alla sostenibilità che abbracciano ogni fase del ciclo di vita dell’edificio.
Le Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer) sono invece il secondo progetto di ricerca che abbiamo approfondito con il ricercatore Giovanni Brumana, che ha spiegato quanto siano fondamentali «perché le reti nazionali, allo stato attuale, non sono in grado di supportare la produzione di energia rinnovabile da fotovoltaico che tutti producono nelle ore centrali del giorno, e quindi le Cer nascono come incentivo per convincere le persone a modificare il loro atteggiamento nell’utilizzo di energia rinnovabile».
Tra i due filoni della ricerca il primo è concentrato a trovare un meccanismo che ottimizzi le Cer, e lo studio avviene in collaborazione con il Centro di calcolo dell’Ateneo che supporta il gruppo di studiosi con appositi supercalcolatori. Il secondo invece si occupa di studiare come migliorare i sistemi di accumulo dell’energia rinnovabile e creare delle batterie di comunità.
© RIPRODUZIONE RISERVATA