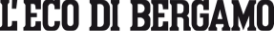L'Editoriale
Lunedì 26 Settembre 2016
L’orrore in Siria
e la cattiva coscienza
I numeri messi in fila sono impressionanti e certificano l’abominio. In cinque anni il conflitto siriano ha prodotto 300 mila morti (100 nella recente settimana di «tregua»), 4,5 milioni di profughi e 7 milioni di sfollati interni (metà dei 23 milioni di abitanti del Paese ha quindi perso la propria casa), il 25% delle scuole distrutte e due milioni di bambini senza più accesso all’istruzione. Un istituto di ricerca specializzato ha calcolato che quando (già, quando?) cesseranno i combattimenti, serviranno almeno 200 miliardi di dollari per la ricostruzione: le condizioni materiali della Siria sono paragonabili a quelle degli Stati europei più colpiti nella Seconda guerra mondiale.
Ma si tratta di numeri in continuo aggiornamento, un libro di orrori al quale continuano ad aggiungersi nuovi capitoli: nello scorso fine settimana la rappresentante dell’Unicef in Siria, Hanaa Singer, dopo i bombardamenti che hanno danneggiato un’importante stazione di pompaggio ad Aleppo, ha ricordato che nella sola città simbolo della mattanza siriana due milioni di persone sono rimaste senz’acqua, con i conseguenti rischi di epidemie, come se non bastasse il resto.
Di fronte a tanto dolore, il giornalista americano Nicholas Kristof, due volte premio Pulitzer, ha dato sfogo alla sua frustrazione dalle colonne del «New York Times» raccontando un’esperienza personale: sui social media ha pianto la morte del suo cane Katie, ricevendo in risposta moltissimi messaggi di commosse condoglianze; nello stesso giorno è stato pubblicato un articolo nel quale Kristof si dichiarava a favore di un più ampio impegno internazionale per far cessare la guerra civile in Siria. «L’articolo - rileva l’autore - ha suscitato un mare di commenti di altro genere, molti all’insegna di una dura indifferenza: perché dovremmo aiutare quella gente?».
Già, perché? In un’epoca di chiusure e di riflusso dalla politica (perfino i pacifisti hanno ammainato la bandiera e non sfilano più nelle strade), appellarsi ai principi umanitari non produce alcun effetto. Conviene invece confidare nella ragionevolezza delle convenienze. I profughi siriani che hanno cercato riparo in Europa rappresentano solo un piccolissimo prezzo da pagare per l’Occidente inerte (peraltro accolti in prevalenza nella sola Germania e nel nord Europa, o confinati in Turchia dopo l’accordo fra Ankara e l’Ue). La Siria ha messo a nudo ben altro: l’assenza di un ordine mondiale dopo il crollo di quello fondato sul blocco bipolare capitalismo-comunismo. In quella terra bagnata dal sangue di un popolo ricco di storia e oggi disgraziato, s’incrociano e si oppongono interessi geopolitici ed economici. Non a caso sono fallite le 17 iniziative di pace in 5 anni di combattimenti.
Tutto ebbe inizio al tempo delle «Primavere arabe», quando le proteste di piazza contro il regime di Bashar Assad (che agisce contro l’opposizione residua ricorrendo all’armamentario di ogni dittatura, dagli omicidi alle carcerazioni alle torture) non intaccarono il potere di Damasco. Il dissenso si organizzò in un Esercito di liberazione nazionale d’ispirazione laica. Ne derivò un sanguinoso braccio di ferro nel quale si infilò nel 2012 Al Qaeda (sotto le vesti della formazione locale Al Nusra) e un anno dopo lo Stato islamico in sfondamento dal confinante Iraq. Ogni sigla con il suo sponsor regionale o mondiale. Oggi con il regime di Damasco sono schierati la Russia e l’Iran mentre gli Usa hanno congelato l’obiettivo di abbattere Assad dopo aver sostenuto invano l’opposizione laica e aver chiuso un occhio sull’avanzata dell’Isis, il mostro poi sfuggito di mano e sostenuto (non ufficialmente, non sia mai...) da Turchia, Arabia Saudita e Qatar. L’uscita dal pantano passa principalmente da un accordo Stati Uniti-Russia: ma i tempi sono stretti perché a novembre negli Usa si vota e fino al prossimo gennaio, quando si insedierà il nuovo presidente, la politica estera americana andrà nel limbo. La Siria ci riguarda perché quell’accordo potrà definire anche i nuovi rapporti fra le due potenze globali. L’isolamento al quale l’Europa occidentale ha consegnato Mosca dopo l’annessione della Crimea è figlio di una scelta poco saggia. Per uscirne, Putin si è reso protagonista indispensabile in Siria, costringendo gli Stati Uniti a inseguirlo e a cambiare giudizi sul dossier siriano. Il presidente russo è spregiudicato ed esteticamente algido ma non è certo stupido.
C’è poi il capitolo della geopolitica degli affari. Tra gli inneschi della guerra ci sarebbe stato anche il rifiuto di Assad al progetto del Qatar che prevedeva la realizzazione di un gasdotto diretto in Europa attraverso l’affaccio sul Mediterraneo in territorio siriano. Uno smacco alla potenza energetica russa sostenuto da Washington. In tempi recenti invece l’amministrazione Obama ha venduto armi per 100 miliardi di dollari all’Arabia Saudita, che è anche partner dell’Italia in affari. Non siamo ingenui: le alleanze dipendono anche da fattori economici e nei territori delle monarchie arabe ci sono il 60% delle riserve petrolifere mondiali e il 40% di quelle di gas. Ma ha ancora senso tenere chiusa la porta ai rifornimenti energetici di Mosca dopo le vicende ucraine e lasciarla aperta ai regimi arabi? Che convenienza abbiamo?
E l’Onu dov’è in Siria? È impegnata nella mediazione fra gli interessi contrastanti descritti e anche non dichiarati dalle parti in causa. Ma le Nazioni Unite, organismo sovrannazionale come l’Ue, sono ciò che gli Stati membri le permettono di essere in base alla quantità di sovranità nazionale delegata. Di questi dilemmi non c’è traccia nel dibattito politico di casa nostra, sempre molto ombelicale. Eppure la domanda «perché dovremmo aiutare quella gente?» ci riguarda. Senz’altro perché il conflitto siriano è terreno di coltura dello jihadismo che colpisce anche in Europa. E poi, se non per mondare le cattive coscienze assuefatte agli orrori, perché in gioco c’è l’urgenza di un nuovo ordine mondiale, più giusto e più responsabile. L’alternativa è solo il caos.
© RIPRODUZIONE RISERVATA