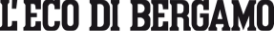L'Editoriale / Bergamo Città
Martedì 22 Gennaio 2019
Il colpevole del male
e la libertà degradata
Capita sempre più spesso, quando ci imbattiamo in un fatto di cronaca di particolare efferatezza, di assistere, perfino sulla stampa, ma ancor più sui social, a reazioni che additano e urlano la mostruosità del colpevole, vero o presunto che sia. Non intendo qui soffermarmi sull’opportunità della sospensione garantista del giudizio. Vi è un altro problema, che è a monte dell’accertamento della colpevolezza. Mi interessa cioè riflettere su questa frettolosa qualificazione del colpevole come reietto, esemplare di un male diabolico e assoluto. Non si intende ovviamente negare che il male ci sia e che venga fatto; e neanche che lo si possa e anzi che lo si debba giudicare, moralmente e giuridicamente. Ciò che lascia perplessi è la qualificazione di quel che accade e soprattutto di chi lo compie come mostruoso o diabolico, quando questa operazione sottenda il tentativo di tracciare una rassicurante linea di demarcazione tra un’area dell’umano e una del disumano, da cui chi giudica si sente immune.
È una separazione che vorrebbe essere tranquillizzante, ma che pretenderebbe di cristallizzare due fronti: quello nel quale militano i cittadini del bene; e quello in cui alligna il male e i suoi mostruosi adepti. Rispetto a questa pretesa, mi pare condivisibile l’ammonimento recentemente formulato dal filosofo Preterossi: «L’umanità è il problema, non la soluzione». Se l’umanità è il problema, vuol dire che nessuno l’ha originariamente risolto, ma che deve conquistarsi, tra e con gli altri, come umano. La società degli umani è infatti un organismo diverso e molto più delicato rispetto a ogni altro esemplare biologico di vita organizzata: se nell’organismo biologico è il male (in termini di malattia), e non il bene (la salute), a costituire un problema, nella società umana vale il contrario: a fare problema - come ha scritto il giurista Supiot - è la definizione dell’ordine sociale giusto, continuamente contestato e insidiato. Ed è nella ricerca di questo ordine che l’umanità è continuamente da istituire e da promuovere, anche attraverso la definizione di una «misura» della stessa libertà individuale.
Anziché esservi iscritta una dimensione preformata di autonomia e di libertà che possa valere da infallibile guida nelle scelte individuali, nell’essere umano – come attesta tragicamente la storia – alberga sempre la possibilità della degradazione e della barbarie, sia verso se stessi, sia verso gli altri. L’umanità stessa dell’uomo, a cominciare dalla libertà, è dunque da istituire, nel senso che è una conquista da accompagnare, incoraggiare e proteggere. «Stay human», diceva significativamente Vittorio Arrigoni. In questa conquista l’individuo non può rimanere solo. A questo esito concorre la struttura del legame sociale che è variamente intessuta di cultura, di norme morali, interdetti religiosi e anche - necessariamente - del diritto. Sono queste risorse fondative a offrire la grammatica di senso entro cui ci riconosciamo e leggiamo come parte di un’umanità, a partire da - e all’interno di - una comunità particolare in cui è originariamente iscritta e alimentata la nostra libertà. Non può supplire alla mancanza di questa grammatica il mero riferimento alla libertà individuale, che la modernità incorona, togliendole però il suo necessario orizzonte di senso relazionale. Se slegata dal rapporto con l’altro la libertà degrada a desiderio e fatica a riconoscere il limite. Ed è questo il terreno su cui può germinare un tratto di mostruoso che assomiglia tanto a ciascuno di noi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA