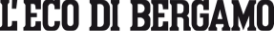Missione Bergamo / Bergamo Città
Giovedì 05 Ottobre 2023
Le famiglie con più figli sono un bene comune, vanno accolte e sostenute
Siamo in pieno inverno demografico. Negli ultimi otto anni l’Italia ha perso un milione e mezzo di residenti. L’indice di vecchiaia aumenta in maniera esponenziale e il tasso di natalità diminuisce anno dopo anno. È urgente invertire la rotta, ma sarà un percorso lungo. Su questi temi interviene Gian Carlo Blangiardo, ex presidente Istat.
La dinamica demografica nella provincia bergamasca risulta allineata a quanto sta accadendo a livello nazionale e riproduce i fenomeni che sono tipici di ciò che ormai viene abitualmente chiamato “inverno demografico”: calo numerico della popolazione, forte crescita della componente anziana (invecchiamento demografico), insufficiente ricambio generazionale, crollo della natalità e crescente deficit nel saldo naturale (sempre più decessi che nascite).
Siamo di fronte a una realtà che faticosamente si può cercare di contrastare, per tutta una serie di fattori che remano contro. Infatti, con il progressivo invecchiamento demografico la popolazione sarà sempre più matura, e quindi anche più conservatrice. Ciò potrà renderla meno aperta all’innovazione, creando limitazioni allo sviluppo, alla crescita, al miglioramento nella qualità della vita.
Bergamo ha anche recentemente vissuto un’esperienza particolarmente drammatica: è stata al centro della pandemia e delle sue conseguenze. Nel 2020 l’aspettativa di vita media provinciale ha subito una riduzione di ben 4 anni rispetto al livello che, dopo tanti anni di continua crescita, aveva raggiunto nel 2019. Di fatto, si è avuto un ritorno a valori di “durata attesa della vita” che si riscontravano 20 anni prima, all’inizio del secolo.
Il colpo inferto dalla pandemia sul fronte della mortalità (soprattutto per le fasce di età più avanzate) è stato indubbiamente molto pesante. In questi ultimi anni c’è stata una ripresa che tuttavia non ha ancora riportato al pieno recupero dei livelli di sopravvivenza dell’epoca precedente il Covid.
Sempre meno bimbi da ventiquattro anni
Se è vero che rispetto ai decessi la fase della pandemia sembra ormai superata, diverso è il bilancio rispetto alle nascite. La provincia di Bergamo prosegue ininterrottamente il cammino verso una natalità sempre più bassa.
Il fenomeno della denatalità viene da lontano, non nasce con il Covid.
Dalla punta massima di 12.080 nati nel 2009 si è scesi nel 2019 a 8.275 (-31%) per poi subire, verosimilmente accentuata dall’effetto Covid, un’ulteriori cadute a 7.673 nel 2020 e 7.696 nel 2021 e stabilire nel 2022 il record di minimo con i 7.461 nati (-38% rispetto al 2009). Ma anche il 2023 non sembra certo aver dato segnali incoraggianti: i dati provvisori dei primi cinque mesi segnano infatti, rispetto allo stesso periodo del 2022 che già è strato un anno di minimo, una ulteriore riduzione delle nascite pari al 5%.
In parallelo c’è il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione. Va anche detto che, nello specifico di Bergamo, la caduta della natalità e l’invecchiamento della popolazione colpiscono soprattutto le Valli, la montagna. Ambiti territoriali tipicamente caratterizzate da quelle minori opportunità di lavoro e di vita per i giovani che alimentano le migrazioni verso le città della pianura.

A queste tendenze di fondo se ne aggiunge una sulla famiglia e sulle sue trasformazioni, avvenute e prevedibili per il futuro. Nella provincia di Bergamo abbiamo, e avremo in futuro, un crescente numero di famiglie, se ragioniamo in termini di posizioni iscritte nelle anagrafi comunali, ma tali famiglie saranno sempre più fragili e con meno componenti. La presenza di fratelli sarà sempre più rara, e la rete familiare, tradizionalmente decisiva nei processi di welfare, risulterà scarsa e debole.
Apporto dell’immigrazione positivo, ma non miracoloso

L’immigrazione in generale offre un contributo positivo alla demografia di un territorio: è una iniezione di giovinezza e di vitalità. Il processo di invecchiamento viene attenuato dall’immigrazione, anche se più che altro viene rinviato nel tempo. La stessa natalità risente positivamente dei fenomeni migratori, perché la loro naturale trasformazione da individuali a familiari introduce un elemento di crescita.
Tutto questo è positivo, ma non è miracoloso. Cioè non arresta fenomeno della denatalità, è una importante ma non risolutiva boccata d’ossigeno.
Se guardiamo i dati sulle nascite in Italia: nel 2012 nascevano 80mila bambini stranieri, nel 2022 sono scesi a 55 mila. E questo nonostante gli stranieri siano aumentati di oltre un milione.
Nel 2008 c’erano 22 nati ogni mille stranieri residenti, oggi siamo alla metà (11 per mille).
È evidente che anche gli stranieri cercano soluzioni di equilibrio, oggi fare figli, che tu sia un italiano o uno straniero, è in ogni caso un problema.
Ben venga quindi anche il contributo degli immigrati alla demografia, ma è importante che il fenomeno migratorio non sia subito, ma governato e dia opportunità di piena integrazione e valorizzazione dei soggetti che ne sono coinvolti. E poi c’è anche un altro aspetto importante rispetto alle migrazioni: l’acquisizione di cittadinanza, un fenomeno che ogni anno coinvolge oltre centomila stranieri e una parte consistente di questi nuovi cittadini (oltre un terzo) è rappresentata da minori. Nel 2022 sono diventati italiani 133 mila stranieri nel complesso del Paese, di cui 4.372 nella provincia di Bergamo.

Nell’arco degli ultimi 40 anni abbiamo acquisito una presenza consistente: a livello nazionale siamo a poco più di 5 milioni di residenti stranieri e 1,6 milioni di ex stranieri ora cittadini italiani. Siamo arrivati a quasi 7 milioni su una popolazione di 59 milioni di residenti, non è pochissimo. Oltre il 10% è certamente una presenza importante.
Ed è una presenza funzionale: tutti hanno riconosciuto il valore di questa presenza (spesso proprio per dinamiche familiari, come per le badanti), o per l’imprenditore che non trova operai e trova i senegalesi. Al di là di singoli episodi di imbecillità o di ignoranza, ma si tratta di casi isolati, siamo nella direzione giusta.
Certo occorre non esagerare con aspettative troppo alte legate alla presenza degli immigrati.
È vero che danno un contributo importante – senza per altro ignorare anche gli aspetti problematici che inevitabilmente si presentano - ma non va pensato che l’immigrazione sia la soluzione magica di tutti i nostri problemi, quello demografico in primo luogo.

Teniamo presente che siamo già un Paese che si è dimostrato accogliente. Tra l’altro siamo, tra i Paesi d’Europa, quello che in questi anni da dato più concessioni di cittadinanza (più dei tedeschi). Siamo stati accoglienti e credo lo saremo ancora perché è nella nostra struttura.
Abbiamo una cultura cattolica di fondo, una cultura legata a valori che sopravvivono ai cambiamenti del contesto; siamo un popolo aperto e con un atteggiamento buono e sensibile.
Dobbiamo pertanto fare leva su questo atteggiamento per creare sempre più inclusione, integrazione. Dobbiamo fare in modo che per tutti sia possibile rientrare nella nostra comunità, condividendone spazi e risorse. Il tutto rispettando le regole ma senza dover rinunciare a quelle specificità che sono proprie di ogni individuo (stranieri o italiano che sia), purché siano in linea con le persone e il contesto – culturale, ambientale, sociale – con cui ci si confronta e si interagisce. Questo è, a mio avviso, il modello di immigrazione verso cui dovremmo fortemente indirizzarci anche in futuro.
Essere genitori è una missione
Anche essere genitori è una missione. Oggi il processo di maturazione per assumerla è diventato più lento e faticoso. In linea di massima il desiderio di genitorialità resta attuale e sentito. I giovani hanno ancora l’idea della famiglia, dell’avere figli (anche più figli), poi però le circostanze di vita fanno sì che strada facendo il progetto si modifica e quasi sempre lo si ridimensiona. Perché si studia più a lungo, si cerca un lavoro, lo si trova magari non pienamente adeguato. D’altra parte lo stesso avvio della vita di coppia si è spostato più avanti nel tempo rispetto al passato e così si entra in gioco come genitori più tardi.
Poi, una volta fatto il primo figlio, c’è un momento di riflessione, in quanto il nuovo arrivato genera costi, problemi di organizzazione, rende più adulta e meno spensierata la vita. E allora, o c’è un processo di maturazione e qualcuno (in verità non molti) si immedesima nella missione dell’essere genitori, oppure (la gran parte) si aspettano tempi migliori e si rinvia il passaggio al secondogenito. Ma mentre si aspetta, l’orologio biologico avanza e anche la capacità riproduttiva in termini fisiologici si riduce. Va da sé che in un processo del genere, se si passa dal caso individuale al complesso della collettività, i conti nel bilancio non tornano.
Se per garantire ricambio generazionale occorrono mediamente due figli per coppia, la forte incidenza di figli unici e il non trascurabile numero di rinuncia totale all’averne, rende inevitabile l’esistenza di un deficit di sostituzione genitori/figli e, conseguentemente, la prospettiva di regresso demografico
Se si va alla ricerca delle cause che stanno dietro a tali tendenze, emergono numerosi fattori: il costo dei figli, la difficoltà nella conciliazione tra maternità a lavoro della donna, l’assenza di strutture di cura adeguate e sostenibili anche economicamente, sia per l’infanzia che dopo, sono certamente ai primi posti. C’è dunque un complesso di cause che rendono difficile aiutare le coppie a garantire quello che è il capitale umano necessario al sistema Paese.
Serve un cambio di mentalità da parte di tutti, non solo delle coppie
C’è poi anche un discorso culturale: se una coppia si impegna e si sacrifica nel “mettere su” e nel “far crescere” una famiglia, quella stessa coppia gradirebbe che qualcuno le dicesse «bravi, grazie». Dovremmo poter passare da una logica del «vuoi i figli? Arrangiati sono fatti tuoi» ad una logica del «Sono anche fatti nostri, perché produci e fai crescere una risorsa che è per tutta la società».
Ai cittadini del territorio direi: cambiamo insieme il clima, il modo di vedere (come un bene) le famiglie coi figli. Fare più figli richiede sacrifici, se però abbiamo un appoggio esterno (amico, vicino, supermercato…) la scelta è meno problematica; lo è ancor meno se il Comune si attiva per dare supporti per le strutture, il nido eccetera, che siano accessibili.
Alcuni comuni (purtroppo pochi) hanno introdotto il pacco di benvenuto (pannolini, latte e altro) per accogliere ogni nuovo nato.
È anche quello un gesto amichevole che fa sentire la vicinanza. È una forma di accoglienza che andrebbe valorizzata. Con un po’ di fantasia si possono trovare molte iniziative con cui aiutare ad accogliere i “cittadini di domani”, quelli che pagheranno pensioni e sanità agli adulti di oggi. Ad esempio con i parchi giochi, con interventi che riescano a creare una città o un piccolo comune a misura di bambini.
Anche le imprese sono chiamate a fare la loro parte. Per loro vale forse ancor più il passaggio dal «sono fatti vostri» a «sono anche fatti nostri». Non va infatti dimenticato che il mondo economico già oggi avverte le conseguenze del fenomeno demografico ed è destinato a risentirne in modo drammatico nei prossimi decenni. Sul piano della domanda di beni e servizi e su quello della produzione.
Le previsioni ci dicono che dai 36 milioni di potenziali lavoratori di oggi passeremo a 25milioni nel 2070.
È interesse di tutti che ci sia il capitale umano con cui garantire la produzione, così come le risorse che alimentano il welfare in una società che invecchia sempre di più. Siamo tutti dalla stessa parte. E in questo senso gli imprenditori dovrebbero dimostrare sensibilità e aperture, ad esempio con iniziative di welfare aziendale, per andare incontro ai bisogni della loro collettività di riferimento.
© RIPRODUZIONE RISERVATA