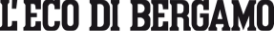L'Editoriale / Bergamo Città
Mercoledì 17 Giugno 2015
Corruzione, è questa
la vera emergenza
In questi giorni il dibattito politico sembra concentrarsi in maniera esclusiva su due grandi questioni, da un lato sull’arrivo di molti profughi e richiedenti asilo che danno un volto nuovo al tema dell’immigrazione e, dall’altro, sull’emersione prepotente ed inquietante, messa in luce dall’azione della magistratura, di fenomeni invasivi di corruzione, di malaffare e di intrecci perversi tra politica e interessi privati. Sulla prima si sono improvvisamente agitati fantasmi di invasioni, delle pandemie e le controversie sono state spinte fino a far divenire la questione una sorta d’emergenza nazionale.
A nessuno (neanche ai più buonisti) è consentito affrontare le problematiche legate ai fenomeni migratori con superficialità. La specificità della situazione attuale (in larga parte generata più da questioni politiche che economiche) chiede attenzioni più complesse e umanitarie che non si possono certo affrontare con i respingimenti e blocchi di confini. Pur rendendomi conto che l’accoglienza genera delle tensioni nel corpo della nostra società e che non è una problematica facile da affrontare, penso non serva a nulla alimentare tensioni e generare capri espiatori del malessere sociale che, a seguito e dentro la crisi economico-occupazionale, ci ha invaso.
Ma la vera emergenza italiana è la corruzione e che il continuo affiorare di profondi intrecci tra politica e malaffare. Al punto cui si è arrivati, a poco servono i moralismi che in questi giorni si spandono a piene mani: con le «grida» non si risolvono le questioni di natura etica ma si finisce col generare antipolitica o col diffondere un disincanto passivo. Servono leggi rigorose, ma da sole non bastano. Sarebbe invece utile ed essenziale il sorgere di una forte indignazione civile e, soprattutto, cercare di comprendere cosa ha consentito l’ascesa di una cultura e di un fare del tutto indifferente alle sorti della cosa pubblica, come le vicende di «Roma Capitale» ci stanno mostrando. Bisogna avere il coraggio di scavare nelle viscere del Paese e cercare di comprendere come mai oltre alla politica siano coinvolti gli stessi corpi sociali. Sembra che le aree dell’innocenza si siano paurosamente ristrette.
Certo, non si può fare d’ogni erba un fascio: ci sono persone, amministratori, imprenditori che ogni giorno, con fatica, cercano di svolgere con onestà e competenza i loro compiti pubblici e sociali. Il problema di fondo è dentro la metamorfosi che in questi anni ha trasformato il senso della politica. Si era pensato dopo le tristi vicende di Tangentopoli potesse iniziare una nuova stagione, oggi dobbiamo con amarezza costatare che così non è stato. Nello stesso tempo dobbiamo renderci conto che se si indebolisce il sentire politico – inteso come confronto dialettico, di progetti, «vision» diverse, comunque tese al bene comune – subentra un adeguamento all’esistente, un ripiegarsi sul presente e sugli interessi. Questo spiega anche l’atteggiamento assunto dai nostri partner europei sulla questione dei migranti: se le decisioni politiche dipendono solo dal consenso e non dai drammi vissuti dalle persone, non c’è spazio per la pietà e la solidarietà. La stessa vicenda Greca sembra segnata dallo stesso criterio. Quando l’oggi è dominante non esistono che le fruibilità del momento. Le problematiche evocate sono diverse, ma al fondo mostrano l’indebolimento della politica e il predominare degli interessi.
La democrazia funziona, risolve i problemi, tranquillizza e genera coesione non attraverso l’affermazione del primato del politico sulla società, la forza della decisione, il rafforzamento dei poteri centrali dello Stato, la personalizzazione – obiettivi che possono avere una loro utilità –, ma quando è vivificata da grandi propositi di giustizia sociale, di partecipazione politica, di libertà personale, di creatività economica, sociale e culturale: insomma quando è spronata e mossa da un’ambizione storica e rappresenti una funzione nazionale, europea ed umanitaria. Ma se i partiti e il ceto politico si affaticano nella propria autoconservazione, o nella gestione del proprio «particulare», vuol dire che manca questa ambizione, l’immaginazione, il progetto e la prospettiva storica: è qui che si apre lo spazio per la corruzione e l’intreccio tra affari e politica . Dopo la stagione delle ideologie bisogna che nasca quella dei valori e delle coerenze, senza estremismi e radicalismi, una stagione tesa all’incontro con altri e a far trionfare solidarietà e pietà.
Ecco, lo scrivo a futura memoria: forse sbaglio, ma se non si inverte il cammino sarà difficile che la politica intercetti le istanze più sentite che sono emerse dalle elezioni del 31 maggio, di chi non si è recato alle urne per chiedere un cambiamento e di chi ha usato i ballottaggi comunali per lanciare avvertimenti. Non ci si deve arrendere al pessimismo, alla demagogia, ai populismi o seguire i profeti di sventura che non fanno stimolare e confermare le nostre paure. Ma ci dobbiamo rendere conto che se per delusione ci si racchiude nel proprio privato, se scocciati dal molto che non funziona si chiede al pubblico di non disturbare i nostri affari, la corruzione trionfa e l’umano si contrae.
© RIPRODUZIONE RISERVATA