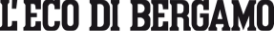Cronaca
Martedì 07 Luglio 2009
Dalle Orobie l'allarme al «G8»:
clima drammaticamente cambiato
E' partito dalle Alpi, già fortemente colpite dai cambiamenti climatici, il messaggio del WWF ai grandi della terra che si riuniranno da domani a L'Aquila. Entro i prossimi 10 anni i ghiacciai alpini rischiano di dimezzarsi ulteriormente e questo avrà effetti sulla biodiversità, sul regime idrico dei fiumi e sulle attività economiche, in primis il turismo.
Il nuovo dossier "Effetto clima per le Alpi" è stato lanciato oggi, martedì 7 luglio, alla vigilia del G8 inaugurando sulle cime delle Alpi Orobie, in Lombardia, una nuova stazione di monitoraggio della flora alpina "in fuga verso l'alto", nell'ambito del progetto pluriennale GLORIA (Global Observation Research Initiative in Alpine environments, www.gloria.ac.at), il progetto internazionale più ampio di ricerca scientifica sulla comprensione dei cambiamenti globali negli ecosistemi alpini di tutto il mondo, dalle Alpi alle Ande e all’Himalaya, attiva dal 2000 con ben 178 siti.
Il progetto è seguito da WWF Italia, WWF European Alpine Programme, Parco Regionale delle Orobie Bergamasche, Centro regionale flora autoctona, Centro Meteorologico lombardo, Università degli Studi di Pavia Dipartimento di Ecologia del Territorio, con il contributo della Fondazione Banca del Monte di Lombardia. Si prevede infatti che alle quote più basse e marginali della catena alpina il 60% della flora ora presente scompaia progressivamente e venga sostituita a causa dell'aumento della temperatura entro il 2080.
Il progetto GLORIA è nato per monitorare la velocità e la direzione di questi cambiamenti e passare dalla fase delle stime alla conduzione di rigorosi studi scientifici di monitoraggio, sia meteorologico che botanico. Il Presidente WWF Italia Stefano Leoni ha dichiarato: «il clima resti tra le priorità del G8 al via da domani. Dai leader del G8 ci aspettiamo una dichiarazione chiara per la riduzione delle proprie emissioni di almeno l’80% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2050. E’ il minimo indispensabile e qualunque obiettivo più debole sarà un completo fallimento. Una dichiarazione ferma da parte del G8 invierà un forte segnale al mondo in via di sviluppo e renderà più facile la riduzione delle emissioni anche per le economie in via di rapido sviluppo».
Il presidente del Parco delle Orobie Bergamasche, Franco Grassi, ha sottolineato «Il sopralluogo di oggi ha permesso ai mondi della ricerca, delle istituzioni e delle associazioni di parlare di ambiente con una sola voce. L'installazione di questa stazione di monitoraggio meteo-glaciale ha il duplice valore di valutare oltre che l'andamento climatico generale anche le precipitazioni nevose, a beneficio delle infrastrutture a carattere sciistico, al servizio di milioni di amanti della montagna».
«EFFETTO CLIMA» PER LE ALPI Non solo atolli sommersi nel Pacifico o barriere coralline sbiancate: il clima che cambia sta producendo da anni effetti gravi anche sulla nostra principale catena montuosa come il ritiro dei ghiacciai, la diminuzione delle precipitazioni nevose, la minor permanenza della neve al suolo, l'aumento della franosità e, conseguentemente, con cambiamenti nella distribuzione delle specie vegetali. Tra il 1850 e il 1980 i ghiacciai nelle Alpi hanno perso circa un terzo della loro superficie e metà della loro massa. E dal 1980 si è sciolto un ulteriore 20-30%. Mentre l'estate estrema del 2003 è costata ai ghiacciai alpini un altro 10%. Alle quote inferiori i ghiacciai sembrano destinati a scomparire e si ritiene probabile che entro il 2035 la metà e per il 2050 i tre quarti di tutti i ghiacciai delle Alpi svizzere (Alpi interne) non esisteranno più. Questo risultato è prevedibile anche in assenza di un ulteriore aumento della temperatura. Rendono bene l'idea di quanto sta accadendo alcuni dati specifici ed estremi, come quelli dei grandi ghiacciai svizzeri, che risultano avere perso oltre il 25% della loro superficie dalla fine dell'ultimo periodo glaciale. A sud delle Alpi le estinzioni di corpi glaciali si contano a decine all'anno (15 in media nella sola Lombardia), mentre alcuni grandi ghiacciai hanno perso il 45% della loro massa di ghiaccio. Il trend di riduzione annua dello spessore del ghiaccio sulle Alpi è quadruplicato passando dal periodo 1850-1970 ai giorni nostri. Un parametro molto studiato è la nevosità media, ovunque diminuita, in misura diversa nelle diverse sottoregioni, ma con punte locali di diminuzione del 30-40% negli ultimi 20 anni e una media di oltre il 18%. La situazione peggiore si è registrata nelle Alpi occidentali e in Veneto-Friuli. Rare annate di nevicate eccezionali, come gli inverni 2000-2001 e 2008-2009, confondono la percezione del fenomeno nelle persone e contribuiscono a una comprensione inesatta della situazione.
GLI EFFETTI DELLA DEGLACIAZIONE Per i prossimi decenni ci dobbiamo attendere un vero e proprio un cambiamento drastico del regime idrico dei fiumi alpini, con conseguenze significative sui settori agricolo ed energetico, oltre che sulla biodiversità. Tra gli effetti evidenti ci saranno anche quelli sul turismo, soprattutto quello sciistico e invernale. Saranno più probabili e frequenti le alluvioni considerando anche l’effetto combinato della cementificazione delle sponde e la pressione antropica portata avanti con fondi destinati alla messa in sicurezza. Si verificherà anche una crescente riduzione idrica anche per l'uso insostenibile della risorsa acqua lungo tutta l'asta fluviale. La diminuzione delle nevicate influenza l'apporto ai bacini alpini ma ciò che renderà questa risorsa sempre più rara è l'uso insostenibile. Solo per il bacino del Po il prelievo in concessione è di circa 1850 metri cubi al secondo, a fronte di una portata media annua di soli 1470 metri cubi.
Bisogna attendersi nell'arco di pochi decenni una drastica diminuzione di disponibilità d'acqua per la scomparsa dei ghiacci. Solo a breve termine si avrà l'aumento di ampiezza, livello e potata dei laghi glaciali e prealpini in seguito alla fusione, un repentino, e purtroppo, effimero effetto che influenzerà le economie lungo le sponde di laghi e diminuirà la qualità dell'acqua disponibile per effetto del dilavamento di zone altamente antropizzate.Si ipotizza anche una crisi energetica:il mercato sta investendo molto ora sull'idroelettrico ma è previsto un calo della produzione di questo tipo di energia di almeno il 30% nei prossimi 100 anni a causa della riduzione della portata d'acqua.
BIODIVERSITA' A RISCHIO: NEI FIUMI E SULLE CIME Gli effetti del Global Warming, accanto a quelli direttamente imputabili alla progressiva antropizzazione, fanno prevedere per l'Italia un tasso di estinzione relativo agli ecosistemi acquatici del 60-80% per i prossimi decenni. Sulla terraferma gli animali più colpiti sono lo Stambecco - simbolo della montagna - e la Pernice bianca. Il primo sta subendo una riduzione delle nascite pare per una mancata sincronizzazione tra lo sviluppo e fioritura di alcune specie alpine e lo svezzamento dei piccoli. La Pernice è invece strettamente legata alla diminuzione dell'innevamento e dell'habitat idoneo. La sua strategia mimetica - il colore bianco che assume nel periodo invernale - prevede la presenza di neve. Sarebbe importante chiudere la caccia a questa specie simbolo delle Alpi lasciando il tempo di adattarsi.
FUGA VERSO L'ALTO DELLE PIANTE: IL PROGETTO «GLORIA» Gli effetti del Global Warming più chiari si notano sulle specie botaniche, in particolare sui versanti esposti a sud delle Prealpi, nei quali si assiste ad un rapido innalzamento della quota media di presenza di alcune essenze, fino a documentare delle estinzioni locali, laddove l'altitudine limitata non consente ulteriori spostamenti. Infatti un aumento della temperatura in aree montuose si traduce in una "forza trainante", che innesca flussi migratori di specie verso quote più elevate.
Nel 2007 l'Università di Pavia ha pubblicato uno studio che ha dimostrato come le piante del gruppo del Bernina, sulle Alpi valtellinesi, negli ultimi 50 anni siano risalite in quota in modo consistente a causa del cambiamento climatico, studio che ha confrontato i dati raccolti nel 1959 dal botanico Augusto Pirola, con quelli raccolti da loro stessi tra il 2003 e il 2005. 56 sono le specie migrate a quote più alte da 10 a 430 metri tra cui la farfara e la genziana della Baviera, 25 sono le specie "nuove" trovate dai ricercatori, 15 quelle di cui si sospetta la scomparsa, a fronte di un aumento medio della temperatura nella zona di 1,2 °C.
Il WWF Italia, l'università di Pavia, il parco delle Orobie Bergamasche e il Centro Meteorologico Lombardo hanno unito i loro sforzi nell’ambito del Progetto GLORIA (Global Observation Research Initiative in Alpine environments, www.gloria.ac.at) per fondare una nuova stazione di monitoraggio che, aggiungendosi a quella già presenti a livello globale, permetteranno di studiare sul terreno la variazione delle comunità vegetali in relazione ai dati climatici.
Questa mattina è partita ufficialmente la messa in opera sul campo della nuova stazione Gloria sulle Alpi Orobie Bergamasche: una nuova Target region nelle Alpi meridionali italiane. Essa è composta da 4 vette, sfasate a diversa quota, dal limite degli alberi (circa 1800 m) fino alla vetta più alta (cica 2300 m), valida secondo il protocollo Gloria, cioè scarsa o nulla influenza umana. Vengono installate alcune griglie, al cui interno sarà possibile monitorare, descrivere, quantificare la biodiversità contenuta ed osservarne eventuali spostamenti altitudinali. I dati raccolti nella prima fase del progetto sono stati prima archiviati in un apposito database centralizzato, poi rielaborati dal gruppo di coordinamento (presso l’Università di Vienna). I primi risultati hanno già permesso di descrivere le regioni europee coinvolte a seconda della ricchezza di specie per ogni fascia di quota considerata.
LA CARTA D'IDENTITA' DELLE ALPI: Le Alpi sono una delle ultime regioni naturali con caratteristiche naturali rimaste dell'Europa centrale e ospitano 30.000 specie animali e 13.000 specie vegetali che testimoniano la grande ricchezza biologica presente. Tra le specie animali sono presenti 20.000 specie di invertebrati, 200 uccelli nidificanti, 80 mammiferi, 80 pesci, 21 anfibi, 15 rettili. Tra le specie vegetali oltre 5.000 funghi, 4.500 piante vascolari ovvero il 39% della flora europea, 2.500 licheni, 800 muschi, 300 epatiche. Le specie più note che vivono nelle Alpi sono: l'orso bruno, il lupo e la lince, lo stambecco, il camoscio, il gipeto e l'aquila reale, oltre a un gran numero di specie endemiche (che vivono esclusivamente qui). Le Alpi sono la più importante riserva d'acqua in Europa, portando acqua ai bacini idrografici di grandi fiumi come il Reno, il Rodano, il Po e il Danubio. I dati relativi all'aumento di temperatura sono i più conosciuti, in quanto recentemente molto dibattuti. E' ormai una conoscenza consolidata il fatto che negli ultimi 30 anni vi è stato un aumento netto della temperatura media e che gli anni '90 siano stati il decennio più caldo da oltre 1.000 anni. Sulle Alpi questo è stato particolarmente incidente ovviamente nei versanti meridionali, quindi in particolare in Italia, e soprattutto a basse altitudini, in zona prealpina e dolomitica. Sulle Alpi questo si riflette in particolare su due parametri importanti: l'aumento delle temperature massime e medie estive, e l'aumento delle precipitazioni piovose e di umidità in generale. Il dato dell'aumento medio di oltre un grado della temperatura degli ultimi 150 anni sulle Alpi non dice molto per i non esperti, mentre sono i dati relativi alle precipitazioni e al ritiro dei ghiacci ad essere più comprensibili e a dare un'idea del problema anche ad un pubblico non esperto.
LA STAZIONE DI RILEVAMENTO SULLE ALPI OROBIE: Utilizzando le specie vegetali come indicatori biologici delle condizioni ambientali, è nato il progetto GLORIA (Global Observation Research Initiative in Alpine Environment 2001). La stazione di rilevamento sulle Alpi Orobie sarà la prima nel settore meridionale nelle Alpi gestita da un team italiano e valuterà la velocità dei processi di migrazione ed estinzione che accomunano a livello globale con maggiore o minore intensità tutti gli ecosistemi alpini. Farà parte appunto di GLORIA (Global Observation Research Initiative in Alpine environments, www.gloria.ac.at) la rete di monitoraggio in Europa e nel mondo attiva dal 2000 con ben 178 siti.
Ecco gli scopi del Progetto perseguiti al livello globale: • quantificare i cambiamenti nella biodiversità di floristica al variare dell' altitudine e latitudine, e la loro relazione con le condizioni ambientali (temperatura, copertura nevosa) nei sistemi montuosi. • valutare il rischio potenziale di perdita di biodiversità dovuta ai cambiamenti climatici attraverso l'analisi della distribuzione attuale delle specie. • quantificare i cambiamenti di biodiversità nel tempo attraverso il monitoraggio dei dati sulle vette studiate ad intervalli minimi di 5-10 anni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA